
Cooperazione internazionale. Progetti per l’Africa. 1983-1987.
Elefanti bianchi, mattoni e capimastri. Mi piace pensare ai progetti di aiuto umanitario di quegli anni, come a dei prodromi, per molti versi fondativi di un lavoro svolto a chiusura di un arco trentennale di professione architettonica. Essi testimoniano una differenza. La differenza che intercorre tra una cooperazione interamente prodotta nel paese del cooperatore, nel quale spesso può venire a giustapporsi la mira di un consenso intorno al donor, ed un altra nel quale invece è stato più importante avere prima un confronto ed una verifica con le forze fisiche locali ancora attive, anche in un paese ricevente devastato dalla guerra civile come lo era il Mozambico verso la fine degli anni 80.
Nel paradigma dello sviluppo, creatura dell’oblio fatale della diversità culturale – perdurato fino agli eventi apocalittici dell’11 settembre 2001, a seguito dei quali l’UNESCO decide finalmente di ampliare un concetto di sviluppo sostenibile annettendo la convenzione sulla diversità culturale e i diritti delle minoranze, (artt. 1 e 3 della Dichiarazione Universale) – si annidano tutti gli elefanti bianchi della cooperazione internazionale. Vi si annida la madre di tutti gli elefanti bianchi disseminati sulla superficie del pianeta: il grande progetto del globalismo integralista.
C’è un episodio che spesso mi piace ricordare e che ora giunge l’occasione di mettere per iscritto. Riguarda un aneddoto dei bei tempi andati della scuola di volo all’aeroporto dell’Urbe che un colonnello dell’aereonautica insegnante di meteorologia mi raccontò durante quella mezz’ora che spesso ci prendevamo alla fine della lezione per scambiare una chiacchiera amichevole e conclusiva della giornata. L’aneddoto riguarda un vecchio muratore capomastro il quale venne a costruirgli un muretto, non ricordo bene se di cinta ose per un fabbricato, che ad un certo punto della costruzione il colonnello si fermò adosservare con stupore ed ammirazione. Il modo naturale ed innato con il quale quell’uomoriusciva a sistemare, o meglio a “posare” i mattoni uno sull’altro assolutamente allineati ea piombo senza troppi ritocchi ed aggiustamenti aveva qualcosa di magico e prodigioso, alpunto tale che sembrava come se i mattoni si disponessero da soli al semplice gestosapiente della mano. Ricordo ancora come se fosse ieri la mimica simpatica che riusciva afare il colonnello per descrivere quello che evidentemente somigliava più ad unasomministrazione di un antico rituale che ad una semplice posa di un muro di mattoni.
Ora però non ricordo se gliene feci cenno in quella stessa occasione, oppure mai, ma eraaccaduto anche a me un episodio del tutto simile nel mio passato di co-operatore per unprogetto in Mozambico. Si dovevano costruire dei piccoli edifici in muratura ed io avevocon me un capomastro di un villaggio vicino a Maputo con una squadra di muratori emanovali al seguito sempre del posto. Il metodo di costruire pareti curve in mattoniminimizzando opere provisionali e archi riducendo quasi a nulla le centinature, avevaanch’esso qualcosa di miracoloso. Con poche od assenti correzioni, come in una manolibera di un progetto di Mario Ridolfi, sembrava come se effettivamente quelle pareti equegli archi, adottati per mantenere viva la capacità artigiana locale e l’identità del piccolovillaggio residenziale, fossero predestinati ad assumere quella forma.
In un terzo mondo sconosciuto e sottovalutato il mestiere aveva forse ancora quel sensoche doveva aver avuto nel passato per la nostra cultura, vale a dire, un repertorio ditecniche e ricette del fare secondo la regola di un’arte tramandata con amore da padre infiglio, in una maniera che non è possibile replicare in una scuola o alle dipendenze e abottega come si diceva una volta.
Anche questo muratore mozambicano, come il capomastro italiano del colonnello,custodiva la mistica di quel modo di lavorare che altro non è se non la capacità, insieme aldiritto, di salvaguardare il legame organico esistente tra il mestiere e la qualità, tral’identità culturale locale e l’ecosistema.

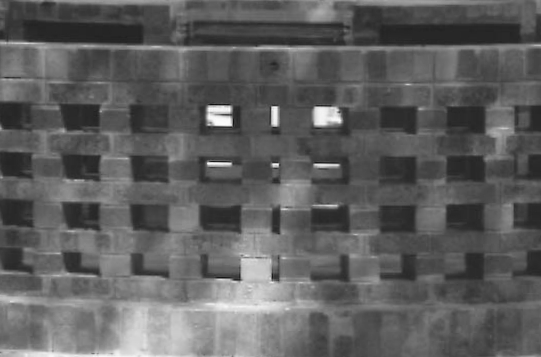
"Riabilitazione ed ampliamento "Estaillero Naval Rio Matola".
Maputo - Mozambico. 1987
In appoggio alla pesca artigianale nella baia di Maputo – Mozambico fu elaborato un progetto di riabilitazione ed ampliamento di un cantiere navale per la costruzione e manutenzione di pescherecci in legno. Il cantiere appartenente alla locale Navipesca, è ubicato a circa 15 Km. da Maputo presso la foce del fiume omonimo. Il progetto iniziò nel Maggio 1987 ed i lavori di riabilitazione nell’ottobre dello stesso anno. Oltre alla progettazione esecutiva, la direzione lavori, e l’assistenza tecnica iniziale per la riparazione delle barche abbandonate sulle rampe di alaggio, il progetto ha previsto la fornitura da risorse locali delle materie prime da destinare alle opere insieme ai macchinari ed alle attrezzature in dotazione al cantiere.
Ma l’aspetto centrale attorno al quale si è potuto ingranare con inconsueta efficacia la routine di un meccanismo altrimenti puramente consuetudinario per interventi di questo tipo, è stata la scelta di aver voluto operare esclusivamente sul posto secondo un procedimento di allocazione, con un processo di scelta sempre in vista dei bisogni del cantiere e delle risorse da usare per soddisfarli.
Eccetto che per la fornitura dall’Italia di alcuni macchinari, si è operato limitatamente alle risorse disponibili di materiali da costruzione oltre che alle energie lavorative locali, re-impiegando a tempo pieno i lavoratori del cantiere rimasti privi di occupazione a seguito della progressiva dismissione del cantiere navale.
Con gli addetti dello stesso cantiere navale e forniture metalliche di piccole officine dell’area industriale di Maputo, utilizzando attrezzature presenti fortemente limitate per numero e qualità, sono state costruite in loco le travi reticolari progettate come elementi modulari da impiegare per le varie situazioni di copertura degli edifici; con il legname di scarto per la riparazione delle barche e il cemento e i tondini ancora disponibili localmente, si sono potute produrre le casseforme e il calcestruzzo armato della rampa di alaggio.
Gli edifici del nuovo cantiere riutilizzano le fondazioni degli edifici preesistenti e parte delle strutture di elevazione. Pensati come corpi di fabbrica staccati intorno alla rampa di alaggio dei pescherecci, sono stati riadattati dopo la demolizione delle parti fatiscenti e resi omogenei attraverso un’uniforme tipologia di copertura a tetto inclinato e visiera frangisole perimetrale.
Un approccio alternativo, si potrebbe dire autopoietico, basato cioè sulla nozione di auto-organizzazione e autonomia, che introduce un modo nuovo di considerare la relazione non solo tra cooperazione e paese beneficiario, ma anche tra artefici e artefatto, invitando a ripensare i termini nei quali si vengono ad attuare crescite di sistemi anche ben più complessi, come i grandi sistemi urbani.





